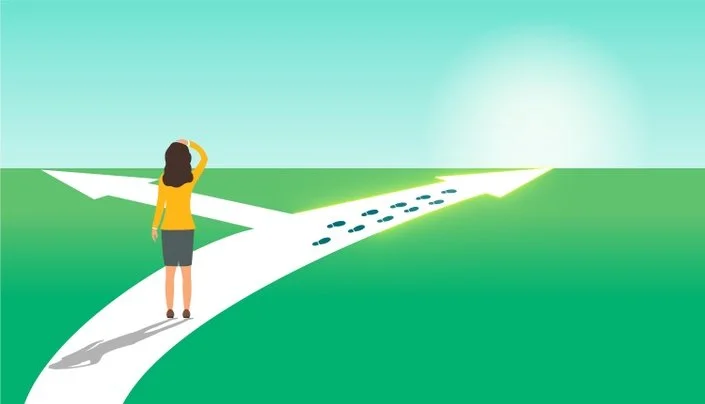Perché tanta resistenza verso la neuroarchitettura?
/Credo che il motivo di una difficile applicabilità dei principi di neuroarchitettura (e di quelli della psicologia ambientale), specialmente negli ambienti istituzionali e commerciali, risieda nella tensione tra l’organizzazione formale e quella informale.
La prima è una esigenza dettata dai programmi già adottati, da pacchetti preconfezionati e più accessibili sia dai costruttori che dai progettisti, e sono più comprensibili e accettati anche da gestori e finanziatori. La seconda, l’organizzazione informale con le sue regole non scritte e quasi sempre disattese, riguarda la nostra spontanea reazione o pulsione verso il contesto in cui siamo immersi. Essa è sconosciuta in principio e resa palese solo in seguito, ad occupazione avvenuta. Le figure professionali chiamate in gioco non hanno né forte consapevolezza né controllo su queste sensazioni. Queste si rivelano solo in un secondo momento, e non nelle loro reali vesti, ma camuffate come disagio, come effetti collaterali di interventi considerati assolutamente legittimi che vanno controllati. L’unico virtuosismo nel campo della progettazione sembra manifestarsi nel “post occupancy evaluation”, che più che altro tende a tarare il sistema impiantistico con il controllo dei parametri fisiologici, piuttosto che quelli psicofisiologici o strettamente psicologici. Un approccio, questo collaudato, che non riesce a cogliere tutti gli aspetti tipici dell’organizzazione informale, la quale sembra solo apparentemente generarsi in modo anarchico e casuale, mentre invece è il risultato di processi di assestamento di sistemi complessi che possono essere studiati a monte.
Perché se da un lato ci sono i parametri fisici, come i volumi, le rifiniture e i layout di arredo, dall’altra ci sono i setting comportamentali, quelli che R.G. Barker - della tradizione lewiniana - già negli anni 60 studiava e definiva come eco-comportamentali, e non perché studiasse il rapporto delle persone con la natura, ma perché asseriva che fossero comportamenti che naturalmente scaturivano dal contesto, soprattutto da quello costruito.
Quando si parla delle origini della psicologia ambientale si fa sempre riferimento alla ricerca di Ulrich del 1984, un momento di rivelazione che spiega e dichiara ufficialmente l’importanza della vista di un paesaggio naturale per il recupero del benessere non solo psicologico ma soprattutto fisico di un paziente in ospedale. In realtà il campo di indagine nasce ufficialmente oltre 30 anni prima, a New York, dove la municipalità della capitale decideva di finanziare un'indagine al National Institute of Mental Health per studiare gli effetti che l'assetto architettonico dell'ospedale psichiatrico potesse avere sui pazienti. Il filone nasceva negli USA ma stentava a diffondersi in Europa, tant’è vero che solo dopo un decennio dall'inizio delle prime pubblicazioni americane esce in Inghilterra, nel 1981, il primo numero del Journal Of Environmental Psychology.
Tale tensione e resistenza è stata ancora più forte in Italia , che fino a qualche anno fa rimaneva l'unico paese europeo a registrare un assenza totale di collaborazione tra la pratica di progettazione e l'indagine psicologica.
A ben rifletterci sembra che la resistenza all’approccio interdisciplinare risulti direttamente proporzionale alla stratificazione e ricchezza culturale del contesto.
Come è possibile che la patria di Vitruvio, di Alberti e di Leonardo non riesca a vedere in questi illuminati teorici una spinta ad andare oltre e affrontare la nuova complessità, piuttosto che un freno?
Dopo tutto studi su dati antropometrici odierni confermano che le misure dell’uomo sono ancora le stesse di quello “ben proporzionato” e rielaborato da Leonardo, con una variabilità della misura inferiore al 10%.
A parte la battuta un po’ cinica, credo che la difficoltà a fare il salto di qualità stia nella varietà degli aspetti da considerare in un progetto. Bisogna offrire risposte che possano competere con i parametri quantitativi dell’approccio più tecnico, il quale risulta vincente perché quasi sempre perché capace di soddisfare meglio le esigenze del mondo normativo e/o politico.
Tutti sono riverenti di fronte all’autorità dei valori numerici, ma non è detto che non si riesca a creare strumenti risolutivi a problematiche più apparentemente soft.
Per esempio affidabili diagrammi di flusso possono restituire o almeno verificare schemi comportamentali, prevedendo criticità legate alla conflittualità o vantaggi legati ad una maggiore coesione e interdipendenza. Possiamo veicolare i processi della mente visiva grazie alle conoscenze consolidate nel campo psico-fisiologico e creare risposte che si adattano a diversi profili di utenza con risposte variegate e flessibili.
Può darsi che sia il termine ergonomia che deve essere sviluppato ulteriormente, perché non è ergonomica solo una condizione che ci fa funzionare bene, ma soprattutto quella che ci fa sentire bene.
E’ forse proprio in questa sottile differenza che risiede il segreto della vera bellezza di un progetto.